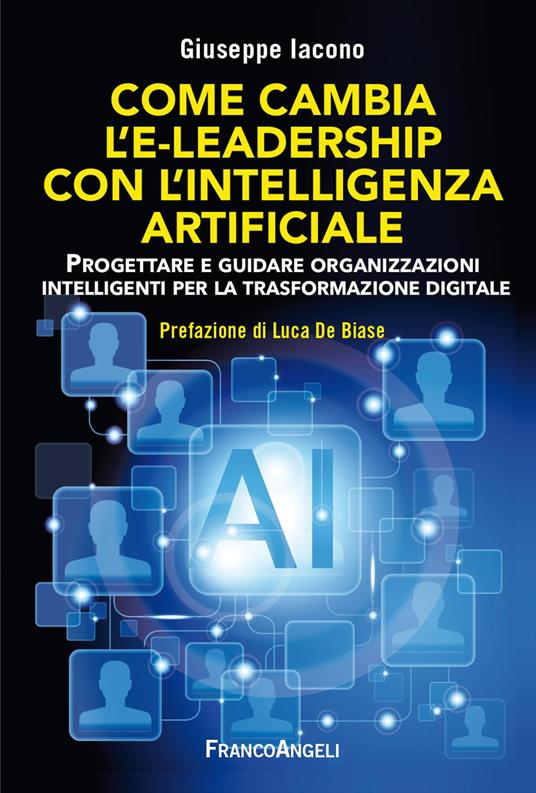Carissimo Bruno (è il nome del mio mentore, ha una lunghissima esperienza, da lui ho imparato il 90% delle cose che so della formazione degli adulti ma soprattutto la consapevolezza dell’importanza che la formazione può avere per le persone). È a lui che mi rivolgo quando mi trovo in un’impasse e decido di chiamarlo:
Come hai visto negli ultimi due/tre anni è cresciuto molto l’uso dei telefonini in aula malgrado le richieste di tenerli spenti o almeno silenziosi, di fare pause da dedicare alle relazioni virtuali, etc.
Le persone ormai vivono la loro vita in una continua connessione (whatsapp, notifiche continue, etc.) e neanche in aula riescono a separarsi, anche per poco tempo, dalla loro condizione che parafrasando Cartesio si potrebbe dire: “sono connesso dunque esisto”.
Personalmente sono molto sensibile al tema, perché l’attenzione in aula dei partecipanti, oltre ad essere il presupposto per l’apprendimento, è per me il carburante fondamentale che mi motiva a fare decentemente il mio lavoro (è un augurio che mi faccio). Lo so che in buona parte è un mio problema perché altri colleghi (buon per loro) invece riescono a non farsi influenzare dalla disattenzione del 30%/40% dei partecipanti più di tanto e portano ugualmente avanti il loro lavoro.
Confesso che non mi sento in buona compagnia se il Ministro dell’Istruzione ha fatto un divieto tassativo dell’uso dei telefonini in aula perfino se utilizzati per scopi didattici.
Bruno, sempre con quella sua aria un po' così (direbbe Paolo Conte… ma non voglio divagare) mi guarda e dopo un po' mi domanda:
“Ma sei sicuro che sia un problema… forse invece di un problema potrebbe essere un’opportunità…prova a pensarci…”
Chiudo il telefono e, dopo un primo momento di confusione, mi metto a pensare. A pensarci bene ora che, anche a causa della tragedia del Covid, tutti o quasi abbiamo un po' più di familiarità con il mondo digitale si può prendere in considerazione l’idea di impiegare queste tecnologie in modo consistente nelle attività di formazione.
E se lo smartphone servisse a qualcosa?
La prima cosa che mi viene in mente è che con questi diabolici smartphone (nome che già contiene un giudizio di valore) le persone possono accedere in tempo reale a informazioni, data base, a volte anche a vere e proprie soluzioni di problemi anche complessi come accade con l’IA generativa (es. Chat GPT).
Potrebbe essere allora che i contenuti e la conoscenza, che sono l’oggetto principe della formazione, non vengono solo e quasi esclusivamente dal docente, ma possono essere co-creati insieme ai partecipanti.
Il compito del docente diviene più quello di una guida, forse un coordinatore, delle attività di raccolta delle conoscenze, delle informazioni e delle analisi che invece sono ora in capo ai partecipanti.
L’aula può servire a fare “esperienza”, un laboratorio dove precipitano conoscenze, problemi da risolvere etc. Al docente il ruolo di individuare dei problemi sui cui chiamare a cimentarsi i partecipanti. Al docente il compito di definire le regole, i vincoli (ad esempio le risorse) e gli obiettivi della ricerca da svolgere.
Ovviamente, rimane il problema della non neutralità della tecnologia e al momento dell’IA. Ma anche in questi casi verificare la neutralità dell’IA può divenire lo scopo di quella determinata attività di formazione. Ad esempio proporre ai partecipanti di ricercare se in alcune risposte dell’AI siano presenti eventuali pregiudizi o giudizi di valore. Nel corso di questi anni spesso ci si è imbattuti in bias di questo tipo e molto attenzione viene ora posta a questi aspetti. Aspetti come, ad esempio, il sopravvivere di pregiudizi di genere nella selezione del personale o di tipo sociale come la provenienza da determinati contesti/territori. In sintesi in alcuni momenti la formazione può essere il luogo per apprendere un uso critico dell’IA generativa. (I presupposti di questa riflessione si possono trovare in Francesco Ciampi, La consulenza direzionale: interpretazione scientifica in chiave cognitiva, Firenze University Press, 2012).

Partire dalla domanda
La formazione al ruolo di problem solver diviene uno degli obiettivi principe dei processi di apprendimento più che, come è ora, di saper utilizzate la conoscenza fornita da altri per applicarla a quel determinato problema. Muovere dalla domanda su come risolvere determinati problemi più che acquisire nozioni che in futuro dovrebbero essere valide per la ricerca delle soluzioni. Chiedere ai partecipanti di ricercare con ogni mezzo a propria disposizione (quindi anche gli smartphone) risposte collettive, condivise e scientificamente valide.
Formazione come una sfida a cimentarsi con problemi reali, anche molto complessi, che non prevedono una sola risposta giusta ma spesso più soluzioni anche per contesti e finalità molteplici.
Provando a realizzare concretamente questo approccio mi sono accorto che, non solo il ruolo del docente e del progettista della formazione è molto diverso, ma soprattutto implica un ribaltamento di come intendiamo i processi di apprendimento. Il compito del docente non è più quello di organizzare la conoscenza per renderla accessibile ad altri, ma quello di affiancare coloro che sono impegnati in un processo di ricerca. Con questo rovesciamento in Francia sono stati raggiunti risultati importanti nell’insegnamento della matematica (Vedi Yves Chevallard e la sua Teoria dell’approccio antropologico alla didattica).
Vi assicuro, perché l’ho sperimentato, per quelli della mia generazione è un cambiamento davvero molto difficile…
Bisogna proprio che chiami di nuovo Bruno.